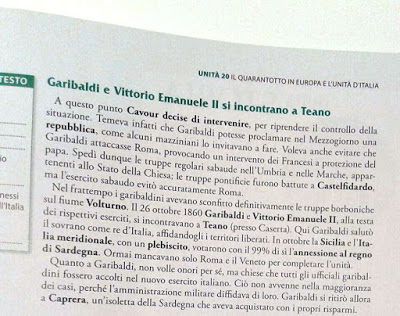Innanzitutto grazie al sign. Di Gregorio per il suo accurato e accorato commento. Mi riempie di gioia vedere come il nostro non sia un blog di “sola lettura”, perché le sue parole hanno cucito attorno alla mia intervista il sottile filo di un dialogo che ha dato a me preziosi spunti e da cui spero ciascuno possa ricavarne altri.
Le mie parole (e insieme di Tomasi) “dovremmo far vituperio
di tutta la Storia e riscriverla come si fa con un romanzo, ma da noi stessi!
Quella sì sarebbe vera Storia”, sono volutamente sarcastiche, di amara ironia. Sappiamo benissimo che la Storia e la
Letteratura sono due approcci completamente diversi alla realtà – l’una
oggettiva e basata su fonti storiche (o almeno così dovrebbe essere), l’altra
soggettiva e basata sulla personale visione di uno scrittore che si fa filtro e
lente per l’interpretazione della realtà stessa - anche se a volte, nel
cosiddetto «romanzo storico» le due tendono a intrecciarsi. Ma, considerate le
verità parziali e distorte che i libri
di storia ci raccontano sul Risorgimento (non è un caso che in riferimento agli
eventi di quegli anni si parli sempre di
«retorica del Risorgimento» o di «mito del Risorgimento», diciture che
tradiscono già una discrepanza fra la Storia e la realtà del fatti), talvolta
il lettore troverà più verità in un romanzo che in un manuale.
Consideriamo, per esempio, i plebisciti di annessione. Lei
scrive che «nel 1860, la stragrande maggioranza dei siciliani partecipò
schierandosi in favore della soluzione unitaria e facendo propria la
parola d’ordine “Italia e Vittorio Emanuele”». Prendiamo in esame un manuale, una fonte
storica e un romanzo.
Le
parole che seguono sulla dinamica delle votazioni sono di Filippo Curletti,
agente segreto di Cavour, modenese che partecipò in prima persona alla gestione
dei seggi nella sua città. Prima di morire Filippo chiamò un notaio e fece le
sue confessioni, immediatamente intercettate e segretate dal governo militare, pubblicate
solo 150 anni dopo. Afferma Curletti:
«Ci eravamo fatti rimettere i
registri delle parrocchie per formare le liste degli elettori. Preparammo tutte
le schede per le elezioni dei parlamenti locali, come più tardi pel voto
dell’annessione. Un picciol numero di
elettori si presentarono a prendervi parte: ma, al momento della chiusura delle
urne, vi gittavamo le schede, naturalmente in senso piemontese, di quelli che
si erano astenuti.
Non è malagevole spiegare la facilità con cui tali manovre hanno potuto
riuscire in paesi del tutto nuovi all’esercizio del suffragio universale, e
dove l’indifferenza e l’astensione giovavano a maraviglia alla frode, facendone
sparire ogni controllo [...] In alcuni collegi, questa introduzione in massa
degli assenti nelle urne, - chiamavamo ciò “completare la votazione”, - si fece
con sì poco riguardo che lo spoglio dello scrutinio dette un numero maggiore di
votanti che di elettori inscritti».
Sottolineo che Curletti è
modenese e afferma che «d’altronde le cose non avvennero diversamente a Parma ed
a Firenze». Figurarsi al Sud! L’On. Angelo Manna, che nel 1991 chiedeva in
Parlamento di desecretare dei documenti che lo Stato tiene ancora oggi
nascosti, nella sua storica interpellanza parlamentare, ribadiva come a Napoli appena
l’1,9 % degli aventi diritto si fosse veramente recato alle urne in quel
fatidico ottobre del 1860. Quel Sud dove i cosiddetti “Briganti”, i quali altro
non erano che patrioti e partigiani in lotta per liberare il loro Regno invaso,
lottarono per più di dieci anni dopo l’“unificazione” e dove lo “Stato
unitario” chiuse le scuole per ben 14 anni (fino al 1875) per evitare che l’insurrezione
si spandesse a macchia d’olio.
Riporto qui di seguito la versione che Giuseppe Tomasi di
Lampedusa dà del medesimo plebiscito nel suo romanzo storico, dalla prospettiva
di Donnafugata. Capitolo III, datato proprio ottobre 1860:
« Alla folla invisibile
nelle tenebre [Don Calogero] annunziò che a Donnafugata il Plebiscito aveva
dato questi risultati:
Iscritti
515; votanti 512; "si" 512; "no" zero.
[...] Il fresco aveva disperso la sonnolenza di
don Ciccio, la massiccia imponenza del Principe aveva allontanato i suoi
timori; ora a galla della sua coscienza emergeva soltanto il dispetto, inutile
certo ma non ignobile. In piedi, parlava in dialetto e gesticolava, pietoso
burattino che aveva ridicolmente ragione.
"Io, Eccellenza, avevo votato
'no'. 'No,' cento volte 'no.' Ricordavo quello che mi avevate detto: la
necessità, l'inutilità, l'unità, l'opportunità. Avrete ragione voi, ma io di
politica non me ne sento. Lascio queste cose agli altri. Ma Ciccio Tumeo è un
galantuomo, povero e miserabile, coi calzoni sfondati (e percuoteva sulle sue
chiappe gli accurati rattoppi dei pantaloni da caccia) e il beneficio ricevuto
non lo aveva dimenticato; e quei porci in Municipio s'inghiottono la mia
opinione, la masticano e poi la cacano via trasformata come vogliono loro. Io ho detto nero e loro mi fanno dire
bianco! Per una volta che potevo dire quello che pensavo quel succhiasangue di
Sedàra mi annulla, fa come se non fossi mai esistito [...]
A questo punto la calma discese su Don
Fabrizio che finalmente aveva sciolto l'enigma; adesso sapeva chi era stato
strangolato a Donnafugata, in cento altri luoghi, nel corso di quella nottata
di vento lercio: una neonata, la buonafede».
(Il Gattopardo, Feltrinelli,
Milano, 2006, pp. 122-125).
Ecco il senso delle mie parole: considerate le bugie e le
omissioni della Storia ufficiale, c’è talvolta più verità nella letteratura che
non altrove, soprattutto quando la letteratura si fa interprete di un’esigenza
di ricostruzione storica, come nel caso del Gattopardo.
E non perché ognuno debba scriverla come gli pare, ma perché nel paradosso
di una “Storia” ufficiale che non ci racconta la verità, un romanzo – in questo
caso il Gattopardo – sa essere più vero della “Storia”.
Con ciò non nego assolutamente l’operato e gli intenti
completamente diversi di chi un’idea di Italia ce l’aveva eccome. Non nego i
misfatti e il malgoverno dei Borbone (soprattutto dell’ultimo, e soprattutto in
Sicilia, lontana da Napoli e perciò non gestita allo stesso modo). Non nego il valore delle insurrezioni che avevano
preceduto il 1861 né le divisioni interne e le debolezze del Regno delle Due
Sicilie, che altrimenti non sarebbe affondato in quel modo (nessun generale si
sarebbe fatto vergognosamente corrompere come il Landi a Calatafimi). Non nego
la volontà di liberazione dallo straniero che ferveva nel cuore di veri
patrioti. Dico semplicemente che il
tutto è finito nell’alveo della strumentalizzazione delle idee, piegate ad
esigenze altre.
Fra qualche anno gli “storici”- o meglio i “propagandisti”
al servizio del potere costituito, che bisogna distinguere dai veri storici - scriveranno sui manuali che i primi decenni
del XXI secolo sono stati caratterizzati da numerosi attacchi terroristici ad
opera di folli kamikaze che terrorizzavano il povero Occidente causa la
diffusione dell’assurdo credo in un dio Allah, in nome del quale si combatteva
una guerra santa contro gli infedeli da convertire a suon di bombe. Ma in pochi
diranno che “jihad” in realtà in arabo equivale al tedesco “Streben”: “aspirazione" "tensione",
una “tendenza infinita al superamento del finito” in direzione di Dio e di un
sé più autentico. In pochi diranno che la strumentalizzazione che ne ha fatto il
potere politico, l’ha trasformata in una guerra tra fratelli, mentre chi vuole
veramente tutto questo rimane nell’ombra. E la storia vera, quella di un ISIS
orchestrato dalla CIA, per autorizzare gli USA a combattere per quelle risorse
economiche, che guarda caso pullulano in quei territori, diverrà “Controstoria
del Terrorismo” - così come le reali vicende del Risorgimento passano oggi sotto l'etichetta di "Controstoria del Risorgimento" -. La democrazia resterà un costume da scena, da far indossare di
volta in volta a questa o quella guerra, per mascherare le vere cause di
appropriazione di risorse che la sottendono. Perché aiutare solo certi popoli a
“conquistare” la democrazia? E gli altri? Gli altri forse non la meritano? No. Gli altri non possono dare nulla in
cambio.
Ecco, la dinamica di "liberazione dallo straniero" di un Regno come quello delle Due Sicilie, governato da sovrani che erano spagnoli sì, ma napoletani da quattro generazioni, mi riporta sulla medesima scia delle "democratizzazioni" forzate di oggi, fatte più per interessi economici che non per un intento reale di Liberazione.
Lei mi chiede perché la definisco «pseudo-unificazione».
- Già nel 1832 Ferdinando II di Borbone aveva proposto al cugino Carlo Alberto di Savoia una “Confederazione di Stati”, ma nel rispetto delle libertà di ognuno di essi, per dare vita ad una compagine territoriale forte e indipendente nei confronti delle mire degli stati stranieri. Il Regno delle due Sicilie, che cercava di difendere a tutti costi il proprio diritto di neutralità, era, inoltre, il più ricco d’Europa dopo le stesse Inghilterra e Francia. Questo chiaramente disturbava l’Inghilterra che, da potenza navale mondiale qual era, non poteva permettere che proprio nel cuore del Mediterraneo – porta d’accesso a ben tre continenti quali l’Africa, l’Asia e l’Europa stessa – dominasse una potenza in continua crescita come quel Regno la cui flotta era passata da 2.387 navi nel 1818 a 9.848 navi nel 1860. Nel 1869 si sarebbe ufficialmente aperto il Canale di Suez e gli inglesi dovevano assicurarsi a tutti i costi il pieno controllo del Mediterraneo a scapito dei francesi e degli stessi Borbone (questo era anche lo scopo del Protettorato e spiega anche la corsa forsennata per quel piccolo pezzo di lava emerso al largo delle coste siciliane già nel 1831). Il Protettorato di cui parla lei, visto da questa prospettiva, acquista una luce del tutto diversa: gli inglesi non ricoprono un ruolo filo-borbonico perché favoriscono i Borbone né tantomeno perché vogliono “ripristinare l’ordine”: essi vogliono assicurarsi di non perdere il controllo su quei territori. Con gli stessi accordi di Plombières ancora Napoleone III sperava di collocare sul trono bonbonico un nipote di Gioacchino Murat, ma gli inglesi non l’avrebbero mai permesso. Spodestare un nemico al centro del Mediterraneo per assistere all’ascesa di uno ancora più grande come la Francia sarebbe stato contro ogni logica. Meglio tenere sotto scacco Cavour e il piccolo Regno del Piemonte, favorire la sua espansione e farlo ri-nascere come stato direttamente dipendente dall’Inghilterra fin dalle sue stesse origini. L’Inghilterra supportava economicamente già da tempo i tentativi del piccolo Regno del Piemonte di inserirsi nello scacchiere politico europeo, poiché aveva intuito che renderlo dipendente da un punto di vista finanziario, sarebbe equivalso ad asservirlo a sé da un punto di vista politico. E così fu: al momento dell’ “unificazione” il Piemonte aveva già un debito di un miliardo di lire con le banche londinesi ed era sull’orlo del fallimento. Come rimediare? Era conveniente per il Piemonte annettere un Regno che aveva due volte più monete (chiaramente indice, oltre che di ricchezza in sé, di una florida economia) di tutti gli altri Stati della penisola uniti assieme. Quello che segue è il quadro della situazione finanziaria dei Regni della penisola al momento dell’annessione.
Quantità di monete circolanti nella Penisola per un tot. di
668 milioni così ripartiti:
Regno delle
Due Sicilie milioni 443,2
Lombardia 8,1
Ducato di Modena 0,4
Parma e Piacenza 1,2
Roma 35,3
Romagna, Marche e Umbria 55,3
Sardegna 27,0
Toscana 85,2
Venezia 12,7
(Da Francesco Saverio Nitti, Scienze delle Finanze, Pierro, 1903, p. 292)
Ma il Piemonte non avrebbe mai potuto sostenere da solo il peso
di quella conquista. Lo stesso Garibaldi nelle sue memorie dichiara: «senza
l’aiuto di Palmerston Napoli sarebbe ancora borbonica e senza l’ammiraglio
Mondy non avrei potuto giammai passare lo Stretto di Messina». Come avrebbero
potuto appena mille uomini conquistare un intero regno nel giro di qualche mese,
se la massoneria inglese non avesse investito una montagna di denaro per "comprare" generali borbonici, bande criminali e pagare lo stesso Garibaldi? Ecco,
io questa non la definirei “unificazione”, ma “corruzione” e “conquista
militare”, peraltro di basso grado, fatta com’era senza nemmeno una
dichiarazione di guerra.
- Non prelude certo ad una degna unificazione uno sbarco fatto in Sicilia assicurandosi prima la collaborazione delle cellule criminali presenti sul territorio. Totò Riina al processo degli anni Ottanta affermò: «Io amo l’Italia, per la quale la mia famiglia ha dato il suo fondamentale appoggio preparando lo sbarco di Garibaldi». E Antonio Patti, mafioso, al Sostituto Procuratore della Repubblica di Palermo nel 1997: «Garibaldi poté sbarcare e spostarsi liberamente in Sicilia perché il Piemonte versò i soldi alla mafia assicurandosene la collaborazione». Non stupisce, al momento dell’instaurazione della dittatura garibaldina in Sicilia, leggere fra i Decreti dittatoriali del 17 agosto: «si ordina dichiararsi nulle, e come non avvenute, tutte le condanne emesse su i fatti, che durante il governo borbonico, si consideravano come reati, ed i condannati doversi intendere rientrati ipso jure nello esercizio di tutti i diritti civili e politici». Lo stesso Rocco Chinnici, capo del Pool Antimafia coadiuvato da Falcone e Borsellino, giudice assassinato nel 1983, affermava: «la mafia come associazione e con tale denominazione prima dell’Unificazione non era mai esistita in Sicilia. La mafia nasce e si sviluppa subito dopo l’unificazione del Regno d’Italia». A Napoli il Prefetto di polizia Liborio Romano, futuro ministro del Regno d’Italia, in segreto contatto con Camillo Benso conte di Cavour e Garibaldi, convocò Salvatore de Crescenzo, capo delle locali bande camorriste, e lo arruolò nella Guardia cittadina insieme ai suoi affiliati. Ora la camorra era in coccarda tricolore e Tore ‘e Crescienzo, forte di legittimazione e protezione, diveniva affermato camorrista. Nell’ottobre dello stesso 1860 ebbe l’incarico di vigilare sulle urne a voto palese in occasione del plebiscito di annessione. Il potere costituito scende a patti con la criminalità, ne legittima l’operato e così si assicura l'assenso dei territori da annettere. Ecco, io questa non la definirei “unificazione”.
- Massimo d'Azeglio pronunciò la famosa frase "Fatta l'Italia bisogna fare gli italiani". Ma ci sarebbe stato bisogno di "fare" un popolo se questo si fosse sentito già tale? Quello che seguì l' "unificazione" fu un abominevole sterminio, che i libri di storia tacciono o citano sotto la semplicistica e fuorviante etichetta di "brigantaggio", lasciando intendere che lo stato unitario dovette quasi sobbarcarsi una immane campagna di lotta alla delinquenza (in un Sud che d'improvviso si era affollato di malfattori rifugiatisi sui monti). E sì che ai veri briganti gli stessi Borbone avevano dato la caccia, ma non erano migliaia, e non avevano le divise borboniche addosso, come quelli che i piemontesi trucidavano ancora più di dieci anni dopo l'Unità; non erano donne, vecchi e bambini come quelli che il generale Cialdini massacrò a Pontelandolfo e Casalduni; non erano inermi contadini come quelli che il generale Pinelli trucidò in Abruzzo e nel Molise. Ogni anno piangiamo sugli ebrei e sulla barbarie nazista, ma nessun giorno della memoria ricorda le migliaia di soldati borbonici (sembra siano stati almeno 70.000) morti nei primi lager della storia europea (molto tempo prima dei più famosi Auschwitz o Dachau!), che venivano deportati a Genova e da lì smistati nei vari campi di concentramento. A Fenestrelle coloro che si rifiutavano di rinnegare il giuramento a Francesco II, venivano spogliati, imprigionati e, malnutriti com'erano, una volta morti venivano sciolti nella calce viva. Ecco, io questa non la definirei "unificazione", ma "eccidio". Ancor più grave se ad essersi macchiati le mani di sangue sono stati quelli che avrebbero dovuto essere loro "fratelli".
Nessuna vena di
rimpianto, dunque, per il Regno delle Due Sicilie, né nostalgia (nel senso proprio greco del termine: nóstos
= ritorno), giacché non si può avere voglia di tornare a qualcosa
che non si è nemmeno vissuto. Da donna del XXI secolo, italiana e cittadina
europea, ex-universitaria che è vissuta per anni a contatto con il resto
d’Italia (che amo e stimo proprio per la sua diversità e per la ricca varietà
di cultura, tradizioni e stile di vita), non sono di certo neoborbonica, né
potrei esserlo. Ciò che sento, e che credo debba essere l’intento che muove
ogni studioso e ogni singolo uomo, è un grande desiderio di Verità.
Valeria Bongiovanni